Bene, direi che è arrivato il momento per il primo mio post “serio” su questa nuova piattaforma, anche se l’inaugurazione di wolfghost.com ha avuto comunque la sua importanza, no? 😉
Chi mi segue da tempo sa che uno dei temi a me cari è quello della morte, ne ho trattato già spesso, sia da un punto di vista umano, parlando ad esempio degli Hospice, che da quello spirituale, con la visione del libro tibetano del vivere e del morire (e non solo).
Il passaggio luminoso, di Marie de Hennezel e Jean-Yves Leloup, cerca di abbracciare entrambi gli aspetti, anche se in vero tutte due sono sempre stati in qualche modo presenti anche nei libri e pensieri di cui sopra.
Marie è una psicologa che lavora da tanti anni negli ospedali di cure palliative, ne è stata, e ne è ancora, una delle principali sostenitrici. Jean è un prete e teologo ortodosso, oltre che dottore in psicologia e filosofia, un esperto non solo di cristianesimo ma anche della visione buddhista e di altre religioni, uno in perenne ricerca della “chiara luce” di cui parlano i testi tibetani.
L’impronta spirituale aggiunta al libro, che tira in ballo anche le famose “visioni” in prossimità della morte, puo’ essere ovviamente percepito come consolatorio, ma leggendo il libro è facile rendersi conto che nelle parole di queste persone c’è qualcosa che va al di là della teoria, qualcosa che è lì, che percepiscono vividamente nella stanza quando il momento arriva e il malato compie il passaggio. Chi parla non è insomma un teorico puro, ma qualcuno che ha vissuto molte volte queste esperienze.
Io stesso, alla morte di mia madre, percepì un senso di sollievo datomi da qualcosa che aleggiava nella camera… come la sensazione che il passaggio fosse ormai stato completato e che qualcuno fosse intervenuto per aiutare mia madre a compierlo.
Certo, si puo’ obiettare che la mente puo’ cercare sollievo in false percezioni create da lei stessa al fine di lenire il dolore, ma… quante volte possiamo dare questa spiegazione, e, soprattutto, è giusto farlo? Perché l’ipotesi consolatoria deve sempre essere quella vera? Non sarà che in fondo abbiamo paura di credere per timore di restare poi delusi?
Cercare di dare una visione non-terrifica della morte è un’impresa, una di quelle che ci fanno esclamare “facile a dirsi, ma…”. E di fatto non lo è facile, gli autori stessi ammoniscono che l’impatto non è solo per chi muore, ma anche per chi ha scelto di stargli vicino. Molti di noi hanno avuto la loro vita cambiata in seguito ad una o più esperienze di “accompagnamento” del morente, in senso negativo certo, ma, a volte, sorprendentemente, anche in senso positivo. Una “buona morte” lascia serenità e forza a chi resta. C’è, oserei dire, una responsabilità anche in chi muore verso chi vive, e non solo l’opposto. Si ha in qualche modo il dovere di non essere completamente impreparati, per sé stessi e per chi si ha vicino.
Negli ultimi mesi della sua vita, la madre di mia moglie, allora ancora bambina, riuscì a trasmetterle una grande serenità, una serenità che ancora adesso la accompagna. C’è in effetti una grande differenza tra me e mia moglie nella percezione della morte. Una differenza che a mio avviso non è solo “caratteriale”, ma è soprattutto dovuta alle esperienze che abbiamo vissuto con i nostri cari.
Vi lascio con un passaggio di Jean-Yves Leloup.
“Essere uomo significa essere humus, terra, essere fragili e deboli. Abbiamo tutto il diritto di piangere, sia morendo sia accompagnando gli ultimi istanti di chi muore. Anche se lo sconforto del morente non ci tocca da vicino, ci commuove perché non siamo insensibili. Chi accompagna, nella sua umiltà, può anch’egli riconoscersi vulnerabile, stanco…
L’angelo dell’umiltà a questo punto arriva, ed è lui che ci rende capaci dell’abbandono, che consente di proseguire fino alla tappa successiva. L’ultima prova in cui la polvere di cui siamo fatti, accettandosi come polvere, puo’ infine tornare alla polvere. In essa non ci sono più pretese, né enfasi. Il vento non gonfia più le vele, è già andato altrove, e finalmente accettiamo che il nostro corpo sia come disertato.
In questo modo possiamo fare un grande regalo ai nostri figli o a coloro che ci sono accanto: quello di una morte senza enfasi, senza esagerazioni. La morte di un essere umano il quale, sapendo che il soffio che ha gonfiato le sue vele non gli appartiene, può mollare gli ormeggi e lasciar andare la barca nel vento: lui stesso è diventato il vento…”








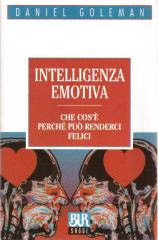 E’ inutile saper risolvere problemi logici quando l’emotività ci gioca un brutto tiro e andiamo nel pallone: qualunque sia il Q.I. non saremo in grado di risolvere granché. Non a caso libri e teorie come “l’intelligenza emotiva” di Daniel Goleman, hanno avuto grande successo in un recente passato: un elevato Q.I., a fronte di una scarsa capacità di controllo emotivo, non serve a nulla o quasi.
E’ inutile saper risolvere problemi logici quando l’emotività ci gioca un brutto tiro e andiamo nel pallone: qualunque sia il Q.I. non saremo in grado di risolvere granché. Non a caso libri e teorie come “l’intelligenza emotiva” di Daniel Goleman, hanno avuto grande successo in un recente passato: un elevato Q.I., a fronte di una scarsa capacità di controllo emotivo, non serve a nulla o quasi.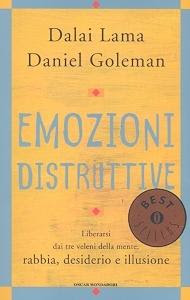
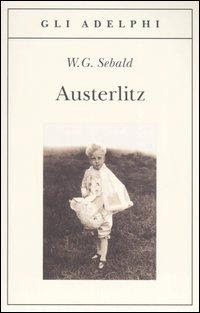 Winfrid Georg Sebald è nato nel 1944, ha lasciato la Germania a venticinque anni non potendo più tollerare quel silenzio con il quale la generazione dei padri continuava a nascondere i crimini e le sofferenze provocate dal nazismo e da una guerra devastante, incapaci di confrontarsi con un passato.
Winfrid Georg Sebald è nato nel 1944, ha lasciato la Germania a venticinque anni non potendo più tollerare quel silenzio con il quale la generazione dei padri continuava a nascondere i crimini e le sofferenze provocate dal nazismo e da una guerra devastante, incapaci di confrontarsi con un passato.
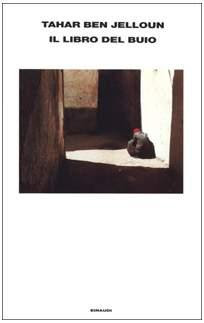 Il libro del buio di Tahar Ben Jelloun, racconta la prigionia di alcuni partecipanti al golpe fallito del 10 luglio 1971 in Marocco. I golpisti vengono rinchiusi nella spaventosa prigione di Tazmamart, dove le celle somigliano a delle tombe, scavate come sono nel terreno e dove non arriva mai la luce. E in effetti la condizione che accomuna i prigionieri è proprio quella di morti viventi, senza voce, né diritti, e in un luogo senza tempo e senza memoria, rimarranno rinchiusi, quei quattro che riusciranno a sopravvivere, per ben diciotto anni, esattamente in una specie di buco lungo tre metri e alto circa un metro e mezzo, dove non era possibile nemmeno stare in piedi.
Il libro del buio di Tahar Ben Jelloun, racconta la prigionia di alcuni partecipanti al golpe fallito del 10 luglio 1971 in Marocco. I golpisti vengono rinchiusi nella spaventosa prigione di Tazmamart, dove le celle somigliano a delle tombe, scavate come sono nel terreno e dove non arriva mai la luce. E in effetti la condizione che accomuna i prigionieri è proprio quella di morti viventi, senza voce, né diritti, e in un luogo senza tempo e senza memoria, rimarranno rinchiusi, quei quattro che riusciranno a sopravvivere, per ben diciotto anni, esattamente in una specie di buco lungo tre metri e alto circa un metro e mezzo, dove non era possibile nemmeno stare in piedi.
 PREFAZIONE del libro “I figli non crescono più”, di Paolo Crepet
PREFAZIONE del libro “I figli non crescono più”, di Paolo Crepet L’esistenza non è una corsa di cento metri, ma una maratona meravigliosa e per arrivare alla fine occorre merito, non furbizia; voglia di essere disponibili a meravigliarsi, non infruttuose ricette alchemiche: “un uomo libero agisce sempre in buona fede e non ricorre all’astuzia”, diceva Spinoza.
L’esistenza non è una corsa di cento metri, ma una maratona meravigliosa e per arrivare alla fine occorre merito, non furbizia; voglia di essere disponibili a meravigliarsi, non infruttuose ricette alchemiche: “un uomo libero agisce sempre in buona fede e non ricorre all’astuzia”, diceva Spinoza.